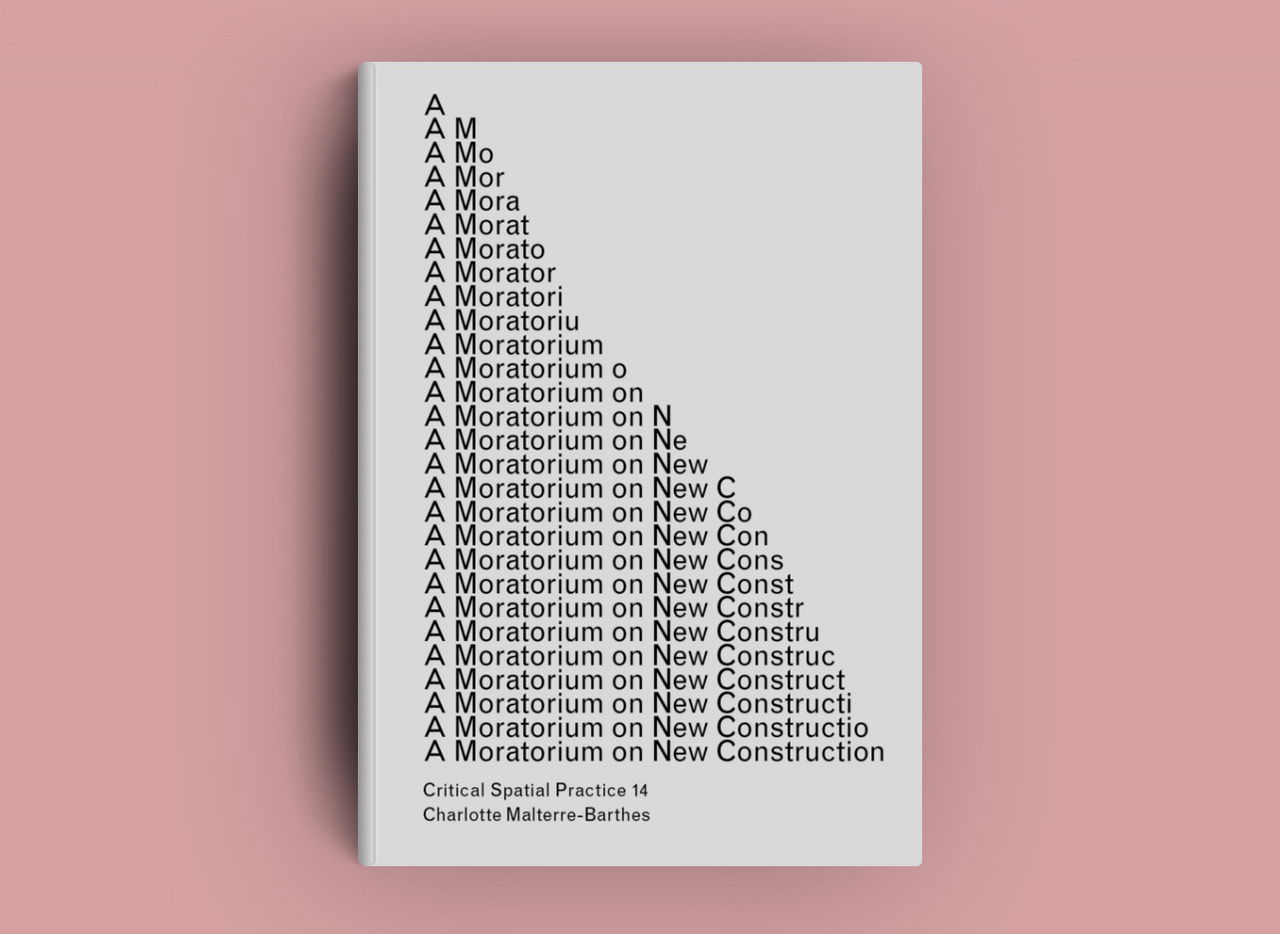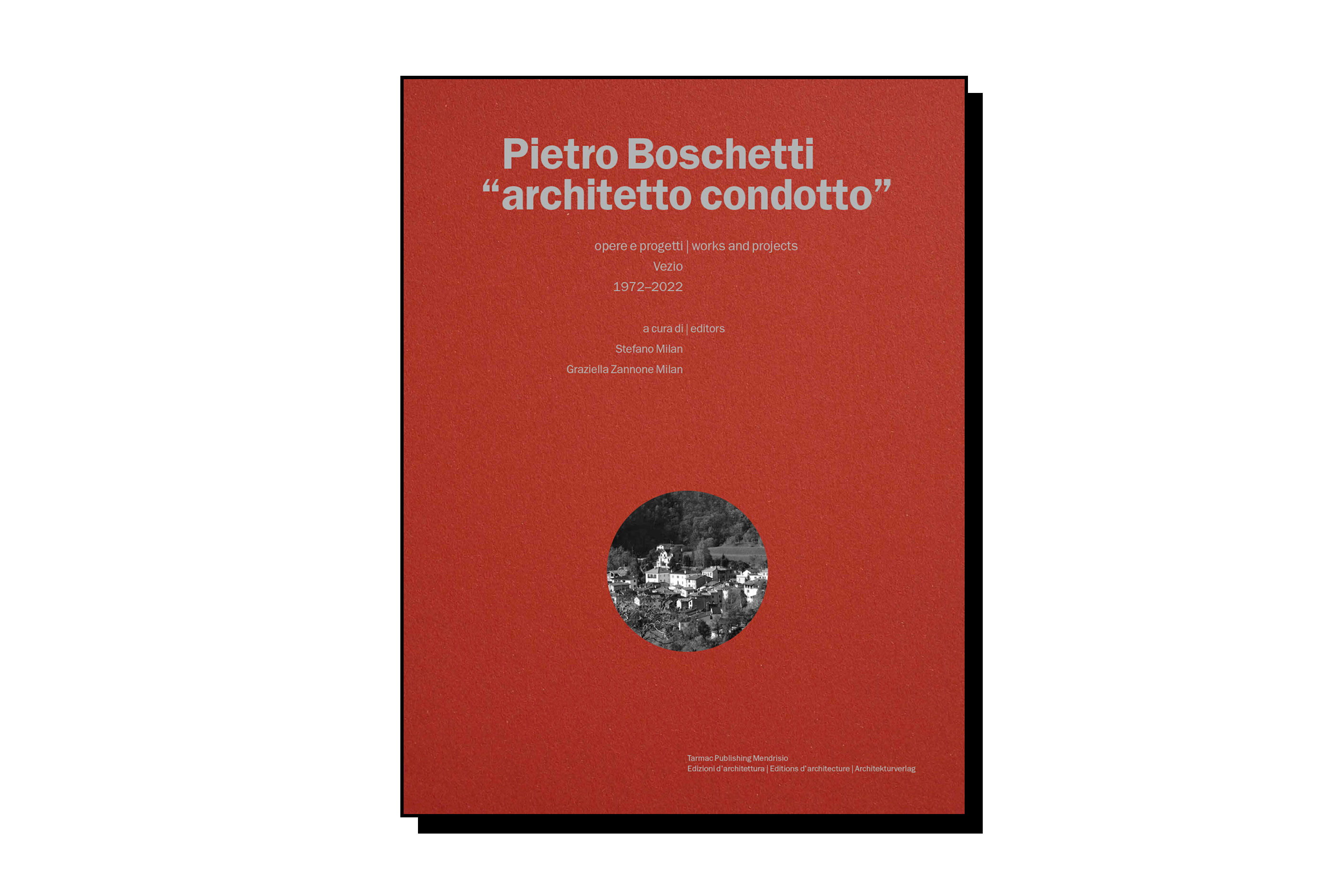Fili Rossi
Il primo capitolo di Fili Rossi, rubrica dei libri di Archi, rintraccia attraverso tre pubblicazioni di diverso genere e contenuto il rapporto articolato che intercorre tra arte e architettura.
«Is architecture art?»
É con queste parole che si apre Architettura e Arte. Negli archivi di BBPR, Dardi, Monaco e Luccichenti, Moretti, il volume curato da Luca Garofalo che introduce il lettore nelle sfumature del rapporto intercorso tra progetto e opera d’arte, attraverso l’analisi degli archivi di alcuni tra i più interessanti architetti del Novecento italiano.
Nel volume, edito da LetteraVentidue, il tema viene affrontato a partire dall’esposizione Architetture a regola d’arte, tenutasi negli spazi del MAXXI di Roma nel 2023, per poi tracciare un percorso tra le esperienze progettuali di pregio che hanno saputo declinare magistralmente il rapporto tra il mondo dell’architettura e quello dell’arte, evidenziando come il lavoro degli artisti abbia influenzato e stimolato la loro ricerca progettuale: «L’oggetto artistico è lo strumento che rende possibile il conformarsi dello spazio dell’architettura», afferma Garofalo intercettando il lavoro dei BBPR nell’allestimento della permanente al Castello Sforzesco di Milano.
Ciò che accomuna gli architetti analizzati ed esposti è la manipolazione del gesto artistico nella definizione di un nuovo equilibrio con il reale: per Costantino Dardi, la centralità del rapporto tra arte e spazio trasporta l’architetto in una dimensione altra, in affinità con il lavoro degli architetti Monaco e Luccichenti, nel quale il limite semantico tra le due arti si fonde, dando vita ad interessanti ibridazioni progettuali.
Il confine tra la pratica progettuale e quella artistica è infatti fluido, spesso indistinto, e riflette sovente la concezione settecentesca secondo cui, se le belle arti possono esistere senza una funzione pratica, l’architettura nasce invece da un’esigenza precisa, con l’utilità e la piacevolezza come fini ultimi, per poi essere perfezionata dal gusto.1 L’intersezione tra le due genera però scenari necessari alla società, evidenziando significati e coinvolgendo il singolo alla partecipazione attiva nello spazio pubblico: «Tutti hanno bisogno di edifici, nessuno ha bisogno di architettura. È un bisogno che si crea con la cultura, in particolare con quegli aspetti che hanno a che fare con l’importanza del “superfluo”. L’arte è la componente essenziale di quella cultura, è vitale che le istituzioni che si occupano di architettura operino quotidianamente per tenere il discorso artistico all’interno della sfera complessa e multidisciplinare dell’architettura».
Dalla necessità di quello che Garofalo definisce come «superfluo» per lo sviluppo di dispositivi progettuali in grado di creare legami con il pubblico, nascono le esperienze raccolte nel volume The home we share, curato da Roberto Behar e Rosario Marquardt. Attraverso diagrammi, planimetrie e fotografie, il libro illustra i tre progetti sviluppati nel 2022 per lo Yeh College e il New College West della Princeton University, aggiunti al già ricco palinsesto di installazioni site-specific disseminate nel campus. Gli interventi, firmati dallo studio multidisciplinare di Miami R&R Studios, in un’ ampia riflessione sul concetto di casa e sul valore dell’ambiente universitario per gli studenti, predispongono per la collettività accademica tre momenti di svago e interazione dal carattere gioioso e poetico, volti ad arricchire l’estensione del prestigioso polo.
Il tema della casa, come spazio di libertà ed espressione architettonica costituisce il focus di Arts & Architecture, la celebre rivista dalla costa californiana che seppe attraversare il Novecento proponendo ai suoi lettori, in una scala sempre più internazionale, esperienze di arte, musica, design, ma anche politica, questioni sociali e, soprattutto, architettura. Inizialmente nota come California Art & Architecture, il successo della rivista crebbe sotto la direzione di John Entenza, dal 1940, con il Case Study House Program, dove convogliarono progetti di Richard Neutra, Eero Saarinen, Charles e Ray Eames, Frank Gehry. Con i contributi di personalità quali Esther McCoy, Lewis Mumford o Peter Yates, la rivista ha spalancato per quasi tre decenni le porte del modernismo statunitense ad un pubblico internazionale, riavvicinando le arti sotto un unico osservatorio culturale: una rivista in grado di sciogliere la dicotomia tra arte bassa e arte alta, avvicinando al grande pubblico talenti emergenti e design accessibile. Il valore della storica rivista è stato celebrato da Taschen, con Arts & Architecture 1950–1954, inserito in una collana di volumi che raccoglie una selezione di articoli e numeri salienti per l’evoluzione di arte e architettura statunitense, e non solo.